Alla scoperta dell’India attraverso gli occhi e il cuore di Veronica, una viaggiatrice che ha composto per noi questo bellissimo diario di viaggio.
Vi indichiamo di seguito le prime due parti di questo bellissimo diario:
Diario di viaggio: in India tra storia e magia – Prima parte
Diario di viaggio: in India tra storia e magia – Seconda parte
Ed ora siamo pronti per leggere tutta d’un fiato la terza parte del racconto. Buona lettura!!
Delhi. Il Gran Bazar.
Con il passare delle ore Giovanni diviene un vero amicone, qualità a cui tende ogni indiano con i turisti occidentali. Non amo i viaggi convenzionali, lo si capisce dal borsone come unico bagaglio e dal solo biglietto come programma. Così lascio che sia lui a stilare la lista delle “cose imperdibili a Delhi”; a pensarci, non è stata una grande idea perché in India, soprattutto chi è in contatto con i turisti, ha tantissimi “amici” produttori di tessuti, spezie, gioielli, lavoratori di marmo che riconoscono loro qualche beneficio per ogni turista che spende nella loro bottega. Questo, Giovanni non l’ha detto, anzi lo ha negato. Faccio così la conoscenza di un simpatico indiano, un po’ trasandato, carnagione scura come i capelli, con una sciarpa leggera che gli copre il collo e la camicia completamente madida di sudore, dettaglio che accomuna tutti in questo periodo dell’anno e in questa Regione, indiani, europei, americani e giapponesi. Lui mastica un inglese migliore ma, a differenza di Giovanni, non ha la patente ed è autorizzato ad accompagnare i turisti solo all’interno di Delhi, mai oltre i confini. E’ un tipo molto curioso, mi racconta di avere una famiglia e dei figli e che non se la cava male, se paragonato a molti altri. Mi promette un’avventura in tutta sicurezza, un’esperienza imperdibile in quella città. Anche con lui contratto il prezzo della sua “gita”, ciò mi garantisce che non stacchi gli occhi da me nemmeno per un secondo, che contratti lui i prezzi di parcheggi e mezzi di trasporto, tutto per pochissime rupie!
Gli spillo qualche parola, scopro che siamo diretti al Gran Bazar, l’infinito e caotico mercato che attraversa Chandni Chowk. La mia curiosa guida mi avvisa che stiamo per prendere un tuk-tuk sul quale avrò la possibilità di muovermi all’interno del groviglio di strade e che, solo a un certo punto, potremo scendere. Avverto un po’ d’ansia in lui, vuole essere sicuro che io abbia capito perfettamente tutto: di non proferire parola con nessuno, di coprirmi le spalle, di chiedere a lui se ho voglia di avvicinarmi a qualche banco (ovviamente può portarmi dai suoi “amici”), di portare lo zaino sempre sul davanti dove tenere conservato il telefonino: “mai tenerlo in mano, anche sul tuk-tuk”, mi rimprovera! Un po’ spaventata da quegli occhi accetto, salgo su quell’instabile eppur comunissimo mezzo di trasporto che sembra volare tra la folla; ogni metro coperto equivale a sciami di polvere, sono costretta a usare la sciarpa per coprirmi naso e bocca e a tenermi stretta a quel tappeto volante per non fare un volo più alto del dovuto. Per tutto il tragitto sull’ottovolante non riesco a parlare perché estremamente ammaliata da ciò che vedo: la loro vita! Tutti sanno esattamente dove andare, si spingono, si fanno spazio; i mercanti meno fortunati hanno una bottega mobile, ma sorridono; chissà perché penso che non devono passarsela male, forse l’ho letto nei loro occhi. Sono affascinata dal susseguirsi di colori misti al grigio della polvere, dalla varietà di oggetti in disuso che riempiono gli spazi; sono stupita dalla fragilità di quei palazzi, dalla debolezza dei muri aperti da crepe, dalla scarna consistenza dei banchetti e, allo stesso tempo, dalla resistenza e forza di ognuno di loro, parte integrante del quadro. Tutto questo mi distrae, mollo per un attimo la presa mentre una buca un po’ profonda ci regala un salto e per poco non volo giù: il mio amico mi guarda, prima con occhi di rimprovero, poi mi addolcisce con una risatina: “siamo quasi arrivati!”. Scendiamo, paga l’autista spericolato – ma comunque nella media; “stammi accanto, e fai attenzione. Quando te lo dico, seguimi per le scale, ti mostro questa meraviglia dall’alto! Non parlare a nessuno”. Sissignore, da buon caporale seguo ogni indicazione con qualche difficoltà perché le persone sono davvero tante e oltre a scansarle (non si spostano!) devo fare attenzione a non pestare bambini e donne seduti per terra, cani che si intrufolano ovunque in cerca di cibo, pile di mattoni lasciati ad aspettare.
L’asfalto è praticamente inesistente, la polvere ha ormai completamente riempito le vie respiratorie e quella sciarpa mi sta asfissiando! Si capisce che siamo in una via interna, trovo bottegai di spezie dai colori magici e cibi essiccati di ogni genere. L’odore è forte, incenso misto a sporcizia e spazzatura. Il caldo aumenta assieme al frastuono, capisco che le mie orecchie non si riposeranno mai sino alla fine di questo viaggio. Finalmente mi fa segno di seguirlo: è una palazzina malconcia, verde chiaro; oltrepassiamo un ingresso senza porta e molto stretto. Indica con un dito la sua bocca, raccomandandomi di fare silenzio (con chi vuoi che parli?). Penso che almeno per un po’ troverò riparo dalla confusione e lo seguo, curiosa. Primo piano, scale strette, mura spoglie, un ingresso separato da un telo; secondo piano, ancora scale strette, il tanfo è quasi insopportabile, una piccola rientranza ci mostra un nascondiglio, ci vedono e si interrompono, il mio amico fa segno di non rallentare. Terzo piano, manca l’aria potrei svenire. Finalmente attraversiamo un arco e giungiamo all’esterno. Siamo sul terrazzo, anch’esso verde chiaro, anch’esso mal ridotto. Il mio amico, entusiasta, mi dice di godermi la vista e che posso fermarmi qualche minuto, lui mi tiene sott’occhio vicino l’arco. Nella vecchia Delhi non vi sono palazzi alti, dunque da quel terzo piano e un po’ ho la possibilità di scorgere qualcosa di interessante.

Alzo lo sguardo. Non è un paesaggio, è uno stupro. Non è una vista esemplare, è una Guernica a colori. I tetti delle case circostanti sono coperti di rifiuti il cui peso, per alcuni, è stato fatale. Altre palazzine sono coperte da lastre di lamiere diventando così l’abitazione di nuove famiglie. Lenzuola e teli gialli sono l’unico riparo e protettori di privacy. Temo di non vedere bene e mi concentro un po’ di più sui particolari. Mi rendo conto di trovarmi sul cordone di un palazzo assai più grande che scopro essere una ex moschea, di forma rettangolare e sormontata, agli angoli, da piccole cupole. Quello spazio è stato pian piano popolato, diventando un insieme di baracche, la dimora di molti. Mi sento estremamente triste mentre alcune voci e clacson mi raggiungono su quel pavimento verde. Ecco che tutte le immagini di questa giornata si uniscono a formare un film unico fatto di strade con marciapiedi inesistenti perché occupati da ambulanti, famiglie senza tetto, rifiuti e materiali accantonati. Altari e templetti fanno compagnia a quel disordine indescrivibile di macchine, motorini, carri a mano. Sporcizia e animali abituano l’occhio a quel caos che ha come sottofondo il vociare delle persone, i clacson assordanti, i campanelli dei carretti. Presa da me stessa mi ero limitata a vedere senza guardare, viaggiare senza vivere. Ed ora è tutto lì, chiaro, uno spettacolo desolante di linee telefoniche in disuso, cavi altezza uomo, piedi scalzi e donne costrette a fare i bisogni per strada per mancanza di bagni pubblici. D’improvviso mi sento pesante, schiacciata dalla povertà come quei tetti di lamiera dalla spazzatura.























.jpg)














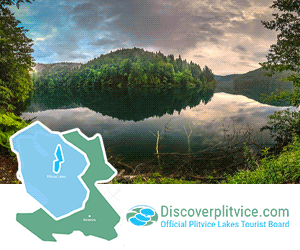







.gif)